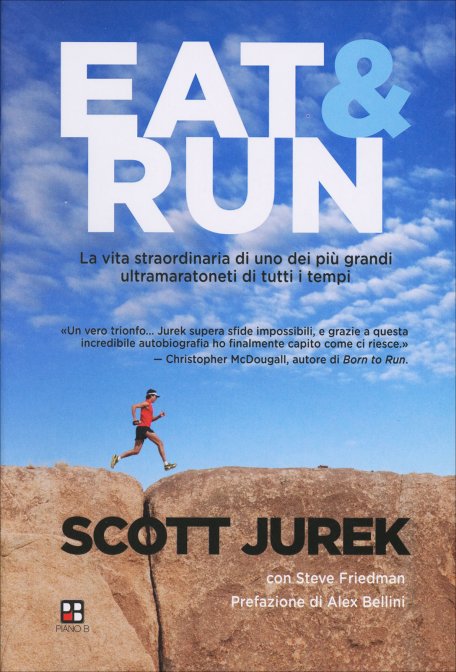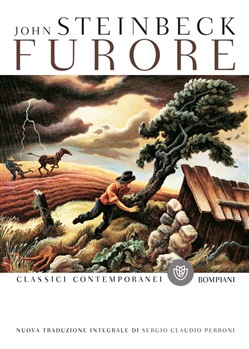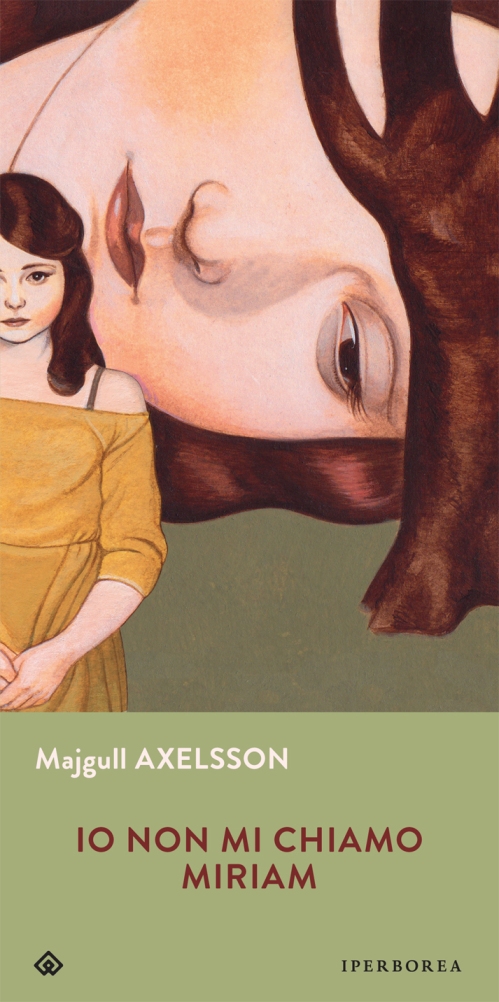Come ci si può sentire se il proprio marito viene assassinato da un gruppo terroristico e il figlio dei tuoi amici, quella famiglia con cui hai condiviso tanti bei momenti, fa parte proprio di quel gruppo di terroristi?
Tanto per cominciare non ci si rivolge più la parola. Ma i rapporti si erano già raffreddati prima che il Txato venisse ucciso. Lui e il suo amico Joxian, per esempio, non andavano più in bici insieme, la domenica, da quando in paese erano comparse scritte minacciose contro il Txato. Joxian aveva tentato di avvicinarlo, di dirgli che non poteva fare altrimenti, che doveva cautelarsi, ma il Txato non era stato neanche a sentirlo, deluso dalla codardia del suo vecchio amico.
Joxian è un uomo mite. È convinto che suo figlio Joxe Mari sia stato molto stupido a entrare nell’ETA , forse sarebbero serviti due schiaffoni in più, chissà. E poi da quando lo hanno arrestato sua moglie Miren è diventata insopportabile, più militante e intollerante del figlio.
Bittori, la vedova del Txato, è il personaggio migliore, a mio avviso. Ogni giorno si reca alla tomba del marito per raccontargli le ultime novità. Come ad esempio la sua decisione di tornare a vivere in paese: tutti ritengono che non sia opportuno, che il suo gesto possa sembrare una provocazione, ma quella è casa sua e lei impone, silenziosamente, la sua presenza. E sempre a toni bassi e con grande gentilezza cerca la verità e un riavvicinamento con i vecchi amici.
Ma il libro non parla solo di questo. La sua forza sta proprio nel mostrare come nella vita della famiglia del terrorista così come in quella della vittima ci sia molto di più. I ragazzi crescono, si innamorano, trovano la loro strada. I rapporti di coppia hanno i loro alti e bassi. Un figlio decide di lasciare la famiglia per andare a vivere con un uomo. Una figlia ha un ictus e rimane invalida su una carrozzina. Ci sono giornate caldissima e giorni di pioggia torrenziale. C’è il desiderio di proteggere un genitore anziano e quello di proteggere figli ormai adulti. E poi, naturalmente, ci sono il terrorismo, l’addestramento, la vita in carcere, le torture.
Il romanzo è a più voci. Ogni capitoletto è raccontato da una voce narrante diversa. Spesso lo stesso episodio è raccontato più volte, ciascuna da un protagonista diverso.
Il racconto non segue quindi una linea cronologica, è tutto un andare avanti e indietro che non confonde, anzi, rende la vicenda sempre più chiara nella sua complessità perché ogni volta si aggiunge un particolare.
Ci sono due elementi che non ho capito.
Uno è il finale, ma questa è una costante, come al solito cercherò di farlo leggere alla mia amica Angela che ha ufficialmente il ruolo di spiegarmi i finali dei libri.
L’altro aspetto che mi ha confusa è il fatto che, dal momento dell’omicidio, è la famiglia della vittima a provare vergogna, a volersi allontanare dal paese, a nascondersi. Mentre quella del terrorista continua tranquillamente ad abitare in paese, senza alcun imbarazzo, anzi, si sente quasi offesa quando Bittori torna a vivere lì. Dev’essere una dinamica comune perché è evidente lungo tutto il libro, viene data per ovvia, come conseguenza naturale.
Infine un appunto all’edizione digitale. Nel testo sono presenti numerose parole in lingua basca. In fondo al libro c’è un glossario con tutte le traduzioni.
Comodissimo nella versione cartacea.
Praticamente inutile nell’edizione elettronica, se non si linkano le parole nel testo 😡
640 pagine.
Indice di regalabilità: 4/5 (sarà apprezzato soprattutto da chi legge molto, da chi sa apprezzare i diversi punti di vista di una stessa situazione, da chi prova a mettersi nei panni degli altri, da chi non ha certezze.
(Di seguito alcune parti che ho sottolineato: a me servono per ricordare alcuni passaggi ma possono anche dare un’idea del tipo di storia e di scrittura a chi si sta lasciando incuriosire. Come sempre, le frasi prese fuori dal loro contesto possono avere un significato limitato o fuorviante. )
Il suo desiderio più grande, essere finalmente da sola, fuori dal campo visivo di consiglieri, di spingitori di sedia, di alimentatori, protettori e persone in linea generale servizievoli che sfoggiavano di continuo con lei le loro prodigiose (muoio dal ridere) doti di pazienza nelle sue diverse sfumature: la pazienza-affetto, la pazienza-compassione, la pazienza-fastidio mal dissimulato, la pazienza-rancore per non aver fatto loro il piacere di morire. Andassero affanculo. Dal pomeriggio della disgrazia non è più padrona della sua vita. E lei voleva stare da sola, cazzo, da sola. Per guardarsi allo specchio? Già, e se pure fosse stato così?
Però un uomo può essere una nave. Un uomo può essere una nave con lo scafo d’acciaio. Poi passano gli anni e
si formano delle incrinature. Di lì passa l’acqua della nostalgia, contaminata di solitudine, e l’acqua della consapevolezza di essersi sbagliato e di non poter rimediare all’errore, e quell’acqua che corrode tanto, quella
del pentimento che si sente e non si dice per paura, per vergogna, per non fare brutta figura con i compagni. E
così l’uomo, ormai nave incrinata, andrà a picco da un momento all’altro.
Questo qui o benedice o tace.
Aveva avuto un pensiero che poi le è tornato molte volte: forse sarebbe stato preferibile morire. Almeno i defunti non costano, non costiamo, fatica.
Uno sbaglio della natura. Perché così come abbiamo le palpebre per smettere di vedere quando non ne abbiamo
voglia, dovremmo poter disporre di due saracinesche nel canale auditivo. Le chiudiamo e non dovremmo più
sentire quello che non vogliamo sentire.